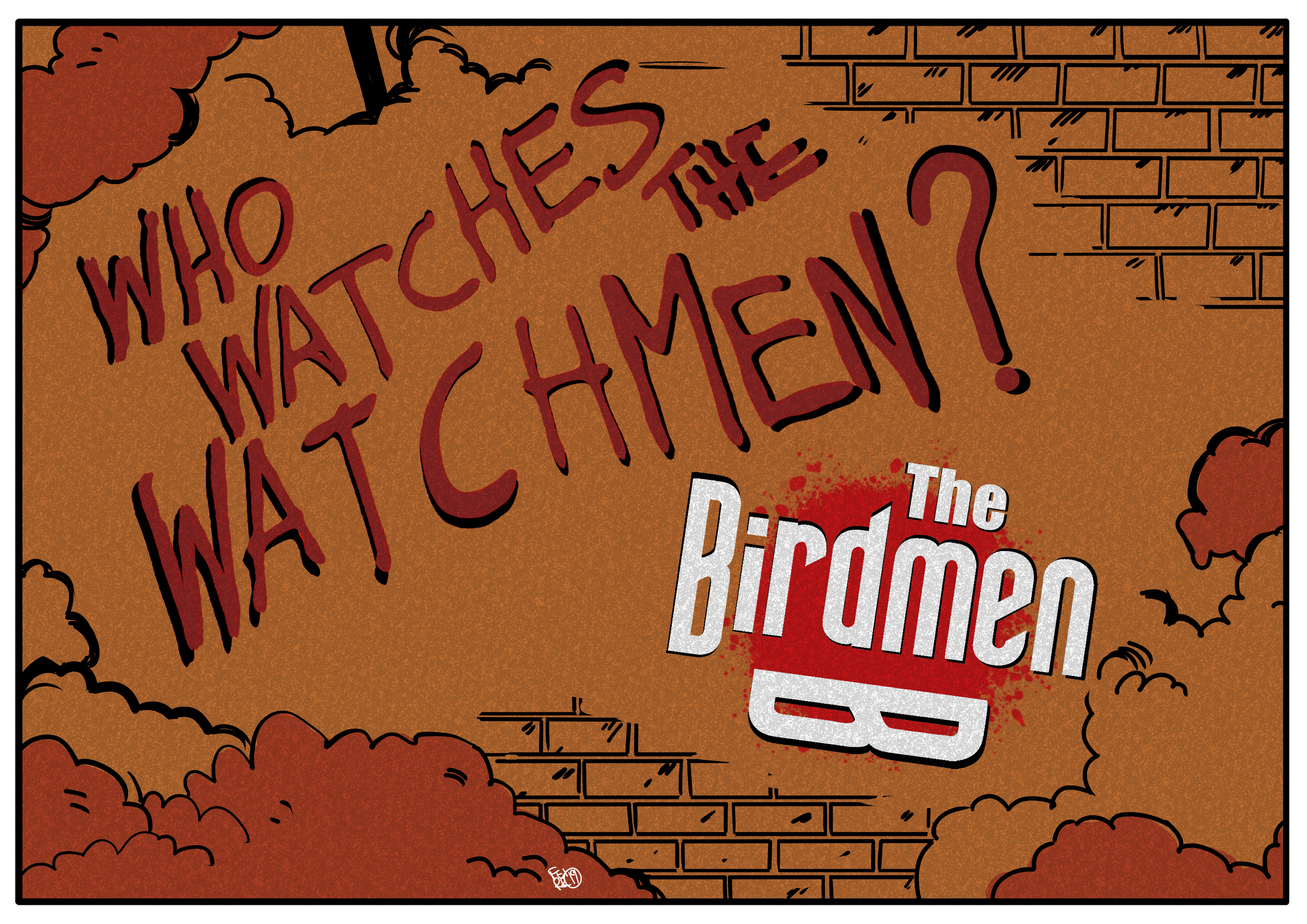
We Watched Watchmen
di Luca Carotenuto, Mattia Napoli e Nicolò Villani
Immagine di copertina di Riccardo Ferrari
A pochi giorni dalla fine della serie HBO su Watchmen, l’universo narrativo creato da Alan Moore nel 1986 e oggi portato avanti da Damon Lindelof in un prodotto di nove episodi ambientato più di trent’anni dopo gli eventi, i nostri Luca Carotenuto, Mattia Napoli e Nicolò Villani si ritrovano in questo articolo a fare ciò che ogni nerd ama fare coi propri prodotti preferiti: parlarne! In una tavola rotonda virtuale, i tre redattori mettono in gioco le loro competenze sul prodotto, sul mondo dei fumetti e sul panorama audiovisivo contemporaneo, filtrando le loro opinioni a proposito dei temi portanti della serie attraverso la loro personale sensibilità. Unitevi a loro in questo dialogo per scoprire (non senza qualche spoiler) ogni sfumatura dell’ultima fatica di HBO!
NV: Durante la visione dei nove episodi della serie, che mi hanno accompagnato settimana per settimana, il tema che più di tutti mi ha fatto pensare è la questione razziale, sia da un punto di vista contenutistico, sia da un punto di vista produttivo. Se da un lato, ripensando al fumetto, è quasi qualcosa di totalmente nuovo nella mitologia creata da Moore, dall’altro non potevo fare a meno di chiedermi perché già il padre del prodotto non l’avesse inserito nella sua visione dell’America. In questo, la mia conclusione più pragmatica sta nella genesi dell’opera: per quanto colto e politicamente impegnato (a modo suo), Moore resta sempre un autore inglese e questo, a mio avviso, ha distorto la sua sensibilità nel momento in cui ha dipinto i suoi Stati Uniti; Lindelof, invece, da statunitense ha colto la palla al balzo per fare di questo lapsus tematico il centro della sua run, in certi momenti esagerando un pelo: se Moore ha attribuito un discreto peso alla questione queer e omosessuale nei primi eroi, Lindelof la “anestetizza” facendola passare in secondo piano rispetto al colore della pelle di un Giustizia Mascherata che appare davvero molto sovra-caratterizzato. Che ne pensate?

LC: Non mi convince molto l’idea della “sovra-esposizione” del tema razziale in Lindelof. O meglio, sì la questione razziale è certamente sovra-esposta, ma non più di quanto faccia Moore nel tratteggiare l’imperialismo e l’autocompiacimento americano. In questo ravvedo una ricercata e curata continuità con l’autore inglese, quella di “caricare” i temi (im)portanti, al limite forse anche dell’esagerazione, ma senza mai scadere nel banale o nel caricaturale fine a sé stesso. La discontinuità con l’autore inizia semmai in una declinazione del tema razziale, che in questo caso riguarda la protagonista, Sorella Notte (una spettacolare Regina King). Angela Abar è in questo senso “l’anti-Rorschach” e non mi riferisco alle sue imprese in costume, men che meno alle sue posizioni politiche, quanto alla sua caratterizzazione. Se il protagonista dell’opera originale è scolpito nel suo marmoreo credo anti-liberale, per quanto mai fanatico, e affronta una serie di prove al termine delle quali rimarrà comunque saldamente ancorato alla sua visione del mondo, Abar invece ricorda molto di più il classico personaggio della narrativa americana, senza dubbio fedele ai suoi principi, ma contro i quali le vicende alterne della sua vita si scontreranno, mettendola alla prova. Per questo Abar è un personaggio molto più tradizionale di quanto non sia Rorschach e in questo posso ravvedere sì la “vena americana” di Lindelof. Quindi no, non credo sia un caso di “sensibilità distorta” o se lo è saggiamente voluto, bensì di strategie narrative, in questo caso sì che risentono della propria nazionalità. Mi spingo a un azzardo: Lindelof è forse un narratore anche più bravo di Moore, sicuramente per quanto riguarda gli aspetti classici di intreccio e trama. Moore però rimane sempre il più rivoluzionario dei due. Ma non deve stupire, del resto oggi gli americani sono “la tradizione”.

MN: Mi trovo d’accordo sull’innegabile preponderanza della questione razziale per Lindelof rispetto ai tanti spunti che Moore aveva tratteggiato nel 1986. Penso però che la risposta vada cercata proprio in quell’anno, se non direttamente nel decennio di riferimento. Piuttosto che concentrarsi sulle diverse nazionalità dei due autori inviterei a fare un passo indietro per osservare il contesto sociale e culturale entro cui Watchmen si muoveva in confronto alla serie televisiva appena conclusa. Il bardo di Northampton fece confluire nella sua penna un clima politico e sociale che impazzava a entrambi i lati dell’Atlantico: reaganismo, thatcherismo, liberismo, conservatorismo, edonismo, insomma, una cornucopia di tematiche dove il razzismo era un elemento sicuramente presente nel dibattito ma non centrale. La venatura di suprematismo bianco che attraversava il personaggio di Rorschach era solo uno dei molti lati di una medaglia fatta di antiliberismo e fede oggettivista, in piena tradizione supereroistica di Steve Ditko. Lindelof dal canto suo si ritrova in un 2019 in cui la questione razziale, la “colpa dell’uomo bianco” e la sua eredità tengono banco maggiormente rispetto a trent’anni fa. Riduce quindi l’eredità di Rorschach a una maschera populista da indossare quanto uno slogan e imposta un affascinante discorso attorno al personaggio di Will Reeves/Giusitizia mascherata sulla ricerca della propria identità, razziale e di genere, da perfetta conclusione del decennio. Due autori, due contesti storici, due bellissime declinazioni.
Continuando il discorso su una impostazione di reazione al contesto culturale quello su cui sono rimasto perplesso per l’adattamento di Lindelof riguarda la tematica più stringente di Watchmen, ovvero la decostruzione del genere supereroistico. Se l’opera letteraria ha avuto l’impatto che ha avuto è proprio per come Moore si è approcciato a tale genere fumettistico a conclusione di un’era e di un percorso autoriale. Watchmen è entrato nella storia con la domanda “chi controlla i controllori?” aprendo la strada a un’era di maturità del fumetto seriale americano e del genere supereroistico. Lindelof, con l’uscita di Avengers: Endgame, si è ritrovato al momento d’apice del genere nella sua declinazione cinematografica e mai il momento sembrava più propizio per dare una nuova stoccata iconoclasta. Eppure, al di là di un sotto testo in cui “chi non vuole una identità segreta?” mi sembra che il racconto non si sia mai interessato a porsi su questi binari. Se c’è qualcosa che però dieci anni di prodotti Marvel ci hanno lasciato è un’idea di super eroe fallibile, ironico e profondamente umano nel miglior senso del termine, l’etica del vigilantismo è un problema che neanche si pone. I nostri eroi insomma sono diversi da quelli che Moore metteva alla gogna. Voi cosa ne pensate: come se l’è cavata Lindelof con l’ingombrante eredità iconoclasta di Watchmen?
![]()
NV: Il primo pensiero, leggendo le tue parole, torna proprio a Giustizia Mascherata, che Moore ci aveva lasciato intravedere e mai del tutto comprendere. È sottile la cosa, ma nell’episodio fatto di flashback della vita di Reeves ci viene mostrato un uomo che legge il primo numero di Superman, dicendo al giovane agente nero che quell’eroe è un alieno che si traveste da terreste (tanto si è detto su quale sia l’identità segreta di Clark Kent); di lì a poco, Giustizia Mascherata sarà anch’egli il primo “vero” supereroe, un nero che si finge bianco quando indossa la maschera. Ad essere messa alla gogna, anche questa volta, è di nuovo la necessità di indossare la maschera, non però come esasperazione del proprio egocentrismo – Veidt ne mostra ancora gli strascichi inattuali – ma come arma di difesa e di attacco: la maschera legittima e protegge i poliziotti, aggrega i terroristi, la maschera, come dice Veidt stesso, ti rende crudele; se vogliamo ancora leggerlo in un contesto fortemente attuale, la maschera rappresentata da Lindelof è quella che si indossa online, in cui ognuno può ergersi a paladino del proprio “ideale”: non a caso, il web è una dimensione pressoché assente dalla serie. In sostanza, a mio parere, il discorso portato avanti da Lindelof è un’interrogazione su quanto la giustizia debba disumanizzarsi per essere tale, trasformando la benda che la rende cieca in una maschera che la rende indistinguibile.

LC: Mi trovo molto d’accordo con l’idea di giustizia disumanizzata, quella giustizia “oggettiva” cioè resa oggetto, da individui senza scrupoli o comunque presuntivamente senza compromessi. E sono anche d’accordo nel voler identificare in ciò un segno della tradizione ditkiana, come suggerito da Mattia, della giustizia senza volto, idea che tanto Moore quanto Lindelof dimostrano di conoscere e rispettare. È altresì vero però che l’altro e altrettanto importante elemento della grammatica discorsiva di Watchmen siano i “mantelli”, in inglese “capes”, che è anche un modo dispregiativo per riferirci agli eroi mascherati. In questo senso il mantello o in generale il costume si rivelano per quello che sono ovvero delle intollerabili protesi dell’ego e della personalità. Un costume può essere un modo per risaltare un’ideologia, un’abilità o può anche rimarcare l’appartenenza a un clan o a un culto. Una maschera può rimarcare un’eredità, come nel caso di Crawford, di cui vergognarsi, o in quello del Settimo Cavalleria, di cui andare fieri. Ciò che la serie mette in risalto a mio avviso è il complicato rapporto col passato, tipico degli americani. La maschera e il costume quindi servono a questo: a oggettivare un’idea immobile e inattuale di giustizia attraverso i decenni o al contrario a esprimerne un dinamismo costante e violento. Ciò che scegliamo di indossare nella serie di Lindelof è quindi prima di tutto la nostra eredità e proprio l’eredità è a mio avviso un altro dei temi portanti del prodotto HBO.
Credo si possano distinguere nella serie due tipi di eredità: quella storica e quella ideologica. La prima è l’eredità toccata in sorte alla protagonista e, come suggerisco dal nome, è un’eredità ricercata, ricostruita e restaurata, piena di contraddizioni e di punti oscuri ma che alla fine riesce a delineare il ritratto “giusto” (inteso come completo) della persona. La verità storica va intesa nella sua complessità, ma una volta ricostruita lascia la libertà alla persona di fare ciò che vuole con quella eredità.
Quella ideologica è un’eredità chiara, lampante e assoluta con tutte le risposte. In questo senso ho trovato ad esempio l’eredità di Rorschach molto ben delineata ma poco illustrata. I lettori del fumetto sanno bene che Rorschach ha lasciato un diario e questo diario con molta probabilità è entrato in possesso di fanatici suprematisti. Ritengo, sopratutto considerando il periodo storico in cui viviamo, in cui i dati e i testi sono sovente storpiati per interessi ideologici, che sarebbe stato quantomeno doveroso illustrare il processo di acquisizione del diario del vigilante, e di come esso sia stato strumentalizzato dal Settimo Cavalleria. Benché infatti abbia apprezzato il lavoro fatto sui suprematisti bianchi, non posso fare a meno di avere qualche dubbio sulla distanza tra il loro pensiero e quello effettivo di Rorschach, che nella serie non è stato illustrato.

MN: Mi trovo decisamente allineato al pensiero di Luca riguardo il concetto di eredità ideologica e quella mezza occasione mancata che è la scoperta del diario di Rorschach. La riduzione del complesso pensiero nichilista del protagonista del fumetto può essere letta ovviamente sotto un’ottica di abile strumentalizzazione in perfetto eco alle numerose riletture contemporanee di opere del passato. Rimane l’amaro in bocca per il mancato sfruttamento di un elemento dal grande potenziale, come sia effettivamente avvenuta quella appropriazione ideologica, reso ancora più marcato dopo il misero – se non a tratti ridicolo – ruolo riservato al Settimo Cavalleria nel finale di stagione.
Più interessante e riuscito il rapporto tra Adrian Veidt (un Jeremy Irons mattatore della stagione) e la sua eredità ideologica, in questo caso un filo tematico recuperato e sviluppato minuziosamente da Lindelof. C’è la splendida idea di prendere il deus ex machina del fumetto e metterlo in un mondo a parte, letteralmente, a rapportarsi con la realizzazione concreta dell’utopia che tanto desiderava compiere per se stesso. Nell’arco di nove episodi, Lindelof fa emergere come il percorso di Ozymandias sia, strutturalmente e tematicamente, la messa in scena del suo scambio finale all’interno del fumetto con il Dottor Manhattan, il quale rispondeva “niente finisce” alla domanda sull’aver “fatto la cosa giusta, alla fine”. In questo caso l’eredità, ideologica e a persino biologica di Veidt, corrisponde a un ciclo temporale ininterrotto e senza conclusione.

NV: In effetti, l’unico personaggio la cui eredità non viene posta in modo nostalgico è proprio Rorschach: Silk Spectre viene ritratta in quella fulminante scena della telefonata a Marte, Nite Owl è evocato attraverso il suo lascito tecnologico, Veidt, come ha giustamente detto Mattia, diventa proprio il perno di collegamento col passato… Però, come per il Comico, la cui memoria è ormai evaporata (ricordiamo che era in ben due formazioni dei Minutemen), ho il sospetto che un motivo da ricercare per l’evanescenza del lascito di Rorschach sia il tempo: sono passati, dopotutto, più di trent’anni dagli eventi di New York e un edicolante di strada ci racconta tranquillamente con che rapidità le persone si dimentichino e disinteressino di grandi personaggi quando non si fanno vivi per qualche tempo. Ho il sospetto che il rapporto polizia/Settimo Cavalleria sia costruito ricalcando i rapporti tradizionali tra gruppi di eroi e di criminali, che diventano sempre più rapporti personali e diretti, in cui la cittadinanza diventa un inconsapevole e ignaro (oltre che disinteressato) danno collaterale. Come penso che pochi americani sappiano il motivo dei cappucci bianchi del KKK, non mi sorprende che non ricordi l’origine di quella maschera macchiata, cosa che fa evaporare in maniera (forse volutamente) snervante tutta l’intensità di Rorschach stesso; dopotutto questo si intuiva da quell’ultima, geniale, vignetta.
Su Veidt, assistiamo invece proprio a un racconto a parte, vero elemento di altissima qualità di questo prodotto: una metafora che oscilla tra il cristologico (mandato da un dio su un mondo a farne da guida, per poi farsi imprigionare), il luciferico (la caduta dal Paradiso) e ricalcando persino il faraonico. Un racconto lucido interpretato magistralmente che ci mette davanti a un’ulteriore decostruzione della maschera: cosa fa davvero un antieroe (a metà tra il Dottor Destino e Mr. Fantastic) di quel calibro, una volta anziano? La risposta è magnetica!
Parlando di Ozymandias, portato in scena da un Jeremy Irons dannatamente convincente e inarrivabile, mi piacerebbe confrontarmi con voi su un problema spesso ignorato, ma fondamentale, nel momento in cui si fa un salto di medium, passando dalla pagina al profilmico: il cast. Ho trovato le scelte attoriali tutte molto misurate e, soprattutto, davvero ben dirette: basti pensare a Tom Mison (Sig. Philips, perlopiù), che viene portato a interpretare lo stesso personaggio adattandolo a più situazioni, fino a quello sguardo finale che tratteggia la delusione in punto di morte. Personalmente non mi ha scontentato nessuna scelta di interprete e ho apprezzato l’energia che i protagonisti hanno messo nell’indossare i panni di personaggi che dovevano reggere l’eredità di una mitologia ingombrante e già degnamente rimediata (nel film di Snyder, se c’è una cosa davvero buona, è il cast).
Se devo trovare una criticità, questa sta proprio nel peso della bravura abbinata all’importanza del personaggio: Veidt e Angela, entrambi magistralmente portati in scena dai loro interpreti, diventano punti di pesante attrazione gravitazionale del profilmico, tanto che quando un personaggio come Looking Glass perde di centralità, non riusciamo più a vederlo se non come una parodia…

LC: Eppure a me Looking Glass è piaciuto. E tanto. È vero da metà stagione perde violentemente importanza ma se c’è una scelta di cast che mi ha colpito come Irons, se non per certi aspetti di più, è proprio Tim Blake Nelson. Specchio Riflesso, come Rorschach, è prima di tutto una voce, quasi un accento, prima che una maschera e sempre come Rorschach subisce una serie di traumi (uno fondativo in particolare) prima di affrontare un prova finale che lo lascerà comunque fedele alle sue posizioni per quanto più maturo.
E l’accento di Specchio è la sua cifra stilistica così come per Rorschach era il contorno dei suoi baloon. Ecco, se dovessi fare una rettifica a quanto ho affermato sopra, direi che sì Sorella Notte è l’anti-Rorschach ma Specchio Riflesso è il vero erede di Rorschach, politicamente anti-tetico, ma strutturalmente simile. Certo non ditelo al Settimo Cavalleria.

MN: Looking Glass è un personaggio dannatamente magnetico, vero erede di Rorschach nell’impostazione iconografica e caratterizzazione, abbuffate di fagioli in scatola incluse. Ode a Tim Blake Nelson e le sue poliedriche doti vocali.
Certo è che finché si tratta di personaggi totalmente inediti la prova attoriale gode di una certa libertà. Discorso differente nel caso di Jeremy Irons e Jean Smart, chiamati a interpretare rispettivamente Ozymandias e Spettro di Seta, gli unici due personaggi originari del cast del fumetto – Dottor Manhattan è un capitolo a parte. Si tratta di due performance diverse e secondo me dalla diversa riuscita, entrambe capaci di aggiungere sfumature totalmente inedite a personaggi che avevamo imparato a conoscere così bene. Jeremy Irons è impostato su una recitazione marcatamente sopra le righe, una mosca bianca rispetto al resto del cast. È affascinante ritrovare il calmo e riflessivo genio delle pagine della graphic novel più vicino alla figura dello scienziato pazzo, e i trent’anni trascorsi dagli eventi lasciano tutto il campo necessario per una simile trasformazione. Il genio di Lindelof sta nell’isolare il personaggio per otto episodi in una storyline dai contorni deliranti per poi farlo deflagrare nel nono episodio lasciandolo a briglia sciolta nel rapportarsi al resto del cast. Ecco che la recitazione tarantolata diventa elemento caratterizzante della superiorità, se non divinità del personaggio al suo ritorno terrestre, tant’è che Jeremy Irons si divora ogni singola scena condivisa con gli altri attori sul finale di stagione.
La bravissima Jean Smart non ha il tempo di introdurre adeguatamente la sua personale Laurie Blake. In trent’anni ne è passata di acqua sotto i ponti per il personaggio e quello che vediamo in scena è una caratterizzazione totalmente inedita, sia per l’evoluzione morale che nell’umorismo e personalità strabordante. In questo caso lo scollamento tra fonte originale e nuova iterazione l’ho trovato troppo forte e senza l’adeguato tempo di accettazione di cui gode Veidt, facendo fatica a considerare la Blake su schermo lo stesso personaggio che conoscevo.
Penso sia doveroso un discorso sul lato puramente tecnico della serie HBO. L’emittente Premium Cable si conferma al solito come la detentrice della supremazia seriale quando si tratta di portare sul piccolo schermo prodotti articolati e raffinati anche al di la della semplice scrittura. Così tanti gli episodi eccellenti di cui parlare che mi limiterò soltanto alla regia di uno, l’ottavo. In A god walks into Abar finalmente il Dottor Manhattan prende la scena, liberato dalla sua gabbia umana alla fine del capitolo precedente sotto le note di una splendida Life on Mars rifatta da Trent Reznor e Atticus Ross (autori dell’eccezionale colonna sonora). Si tratta di un piccolo capolavoro nella forma di un cortometraggio avulso dal resto della serie, l’unico slittamento del punto di vista è relegato a una scena post-credit con Veidt. A voler fare una comparazione l’episodio si avvicina alla resa della fuga su Marte di Manhattan nella trasposizione di Zack Snyder. Se già in quel caso il risultato era soddisfacente, Lindelof e la regista Nicole Kassell (già regista dei primi due episodi della serie) lo superano nettamente in quanto ad ambizione nel rendere l’idea di onniscienza ed eterno presente del Dio blu attraverso un abile gioco di montaggio lungo tutto l’episodio. Ma meriterebbe uguale attenzione l’impostazione del dialogo tra Angela e Manhattan, con il rifiuto etico di dare un volto alla divinità. La presenza magnetica dell’interlocutore di Angela, le battute e piani di ascolto nei diversi contro-campi resi solamente attraverso la gestualità delle mani e leggeri movimenti del corpo. Un lavoro enorme svolto con incredibile perizia, un episodio da applausi.

NV: Mi trovo perfettamente d’accordo e sottolineo un’unico neo di quell’episodio, che è l’inserimento di un paradosso temporale un po’ antipatico… Per il resto, gran lavoro di incastri, che supera quasi l’efficacia fumettistica della resa della percezione temporale compresente di Manhattan (che diventa fondamentale nel suo finale). Dal punto di vista tecnico, inoltre, tutto ha giocato estremamente bene nel restituire quel cinico e freddo realismo grafico che caratterizzava il tratto di Dave Gibbons, con un uso dei colori (soprattutto il blu e il giallo) sempre in grado di ricostruire un’isotopia tematica e un’identità del prodotto più che esplicita. Anche la costruzione delle inquadrature arriva spesso a ricalcare quel gusto per l’easter-egg caratteristico del prodotto di derivazione: pensate ad una delle sequenze finali della serie, con Angela e famiglia che escono dal cinema, e l’insegna di quest’ultimo con accese solo le lettere DR M. Una minuzia eccezionale e, oserei dire, necessaria!
Al pari dell’ottavo episodio, trovo che il sesto sappia porsi sullo stesso piano, con una scelta di palette cromatica inesistente (siamo praticamente sempre nei toni di grigio e nero) che rima con l’origine ideale di Giustizia Mascherata lì narrata: il film da cui Reeves prende ispirazione per la propria maschera. HBO quindi, si, ha voluto dimostrare un’altra volta cosa significa “premium cable”.

LC: A questo punto non rimane da chiederci cosa possiamo aspettarci in eventuali future stagioni. Anche se dopo il sopracitato episodio e in generale in qualunque cosa sia presente il Dr. Manhattan mi chiedo se abbia senso parlare di futuro.
Personalmente non penso subito a una seconda stagione. La storia è in parte conclusa già così ma se potessi decidere qualcosa per il futuro, spero di poter vedere meglio trattati personaggi come Gufo Notturno e Laurie Blake. E una digressione storica sul Settimo Cavalleria.
Infine, mi aspetto tanta “storia” come fatto in questo caso. Poiché la vera innovazione di Lindelof non è stato tanto il tema del razzismo in sé, quanto il fatto di trattare la storia americana, quella vera e autentica e poco conosciuta (io, lo confesso, non conoscevo i fatti di Tulsa). Quindi a me piace Lindelof critico storico e spero di vederlo ancora in futuro.

MN: Concordo sull’esaurimento del filone Dottor Manhattan, se non in generale per il cast di personaggi superstiti dalla graphic novel. A meno di sorprendenti ritorni, i nostri amati Watchmen dovrebbero smettere di indossare il mantello, persino il ruba scena Ozymandias – anche se accetterei volentieri uno spin-off dedicato alle sue avventure in giro per la galassia, magari in compagnia di Looking Glass.
Scherzi a parte, non è facile prevedere al momento quale sarà giusto percorso da intraprendere in un’ottica puramente economica. Non prendiamoci in giro, il successo c’è stato, una nuova iterazione per la HBO è un passo obbligato, si farà e ci sarà, Lindelof o no. Lui ha sicuramente mantenuto la promessa fatta all’inizio del cammino, pur con un finale oserei dire furbescamente aperto, i suoi nove episodi hanno tracciato una storia con un inizio, sviluppo e conclusione. Mi rimetto quindi alle parole da lui rilasciate recentemente in un’intervista: il futuro più intellettualmente onesto della serie è all’interno di essa, nelle infinite storie da esplorare dopo un worldbuilding svolto con tale perizia. Dalle cronache dei primi Minutemen agli eventi accorsi nell’intervallo di trent’anni che ha visto l’elezione di Robert Redford a presidente degli Stati Uniti, sino al mondo sommerso delle piccole maschere e del dipartimento FBI che gli da la caccia. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti, senza dover tornare a scomodare una divinità dalla pelle bluastra.

NV: Ciò che posso sperare io del futuro di questo prodotto, è che non porti a una nuova capillare proliferazione di micro-serie fumettistiche a pioggia, come fu per Before Watchmen, perché nel mucchio è estremamente facile che ci si macchi di superficialità ed eccessiva rincorsa dei numeri di mercato. Ovviamente la tentazione è forte e se fossimo dieci anni nel passato, probabilmente i forum online si riempirebbero di fan-fiction su ogni singolo personaggio introdotto. Per ora mi accontento del risultato e tiro un sospiro di sollievo per non esser rimasto deluso, lasciando che quei vuoti del racconto vengano riempiti dai “se” e dai “forse” generati dalle conversazioni come quella che abbiamo fatto qui.
Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna
Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista

[…] dei supereroi nel “mondo reale” (o comunque realistico): da Kick-Ass a Watchmen, passando per testi meno memorabili come Hancock, prodotti nostrani come Lo chiamavano […]
[…] occasione del nono e penultimo episodio, anche Lovecraft Country – come aveva già fatto Watchmen circa un anno fa – ritorna a Tulsa, sede del massacro noto a tutte le persone nere degli Stati […]
[…] e poco prima c’era stata tutta la rivoluzione di fine anni ’80 con tutte le cose da Watchmen a Man of Steel, tutta quella nuova ondata di autori inglesi che ha rinnovato il mercato americano; […]
[…] la percezione sociale della diversità e la rappresentatività delle minoranze culturali. Qui la recensione alla serie. L. […]
[…] qui su Birdmen Magazine, dopo l’uscita a fine 2019, avessimo dedicato una tavola rotonda a commento di Watchmen, la miniserie HBO firmata da Damon Lindelof che espande l’universo di […]
[…] miniserie di Lindelof, un esempio perfetto per quell’idea di complex tv che negli ultimi anni tanto è invalsa, ha come […]